Dall’assalto alle key box (il sabotaggio delle cassette dove vengono riposte le chiavi degli affitti brevi) alle scritte contro i turisti in montagna, alle manifestazioni di piazza in Spagna: cresce ovunque un movimento di resistenza al turismo predatorio e sempre più elitario, con un impatto non solo ambientale, ma anche economico e sociale, in primis per la crescita dei prezzi delle abitazioni nei centri abitati e nelle aree in prossimità delle attrazioni turistiche.
Agenda 17 continua il confronto con Alfredo Alietti, docente di sociologia urbana, e Romeo Farinella, architetto, dell’Università di Ferrara approfondendo il tema della natura dei movimenti e delle lotte alla gentrificazione e all’over tourism e quello della loro capacità di elaborare, in collaborazione con altri soggetti, progetti che tengono conto della complessità dell’abitare città e territori in trasformazione.
Chi sono i soggetti agenti di queste proteste e lotte? Sono, in una certa misura, collegati al mondo della ricerca (sociale, urbanistica) e/o alle tradizionali forme associative?
Farinella
“Credo che i soggetti agenti siano molteplici, tra cui certamente le associazioni più consolidate e presenti sul territorio, ma non sottovaluterei i movimenti spontanei locali, a Ferrara potremmo citare il Forum Ferrara Partecipata, che spesso riuniscono associazioni ‘istituzionali’ con altre formatesi localmente e con il contributo anche di singoli cittadini, non di rado portatori di conoscenze ed esperienze da non sottovalutare.
Al contrario, è la politica ‘istituzionale’ che spesso sottovaluta tali forme di impegno locali, forse perché troppo autoreferenziale.”
Alietti
“Certe esperienze riflettono una coniugazione tra sapere esperto proveniente dalla ricerca accademica, dalle associazioni ambientaliste e sapere localizzato degli abitanti colpiti da tali processi.
Il gruppo OCIO di Venezia è un esempio paradigmatico in tal senso poiché fornisce, con pubblicazioni, seminari e incontri pubblici, un supporto per costruire un sapere diffuso in grado di fornire le fondamenta delle possibili mobilitazioni.
Questa soggettività socio-politica è sicuramente un fattore positivo poiché alimenta le possibilità di costruire politiche socio-economiche e territoriali alternative al destino, apparentemente già segnato, delle città turistiche e non solo.”
Da questi soggetti può nascere un movimento consapevole e articolato in grado di incidere sulla complessità del fenomeno o si tratta di pura difesa “egoistica” dei propri spazi e interessi?
Farinella
“Non so se possa nascere un movimento consapevole, credo che le due anime (senso della complessità e difesa egoistica) coesistano.
Penso sia necessario un ruolo alto della politica, per dare spazio a queste forme di impegno dal basso per dare spazio e visibilità a queste forme di impegno dal basso, ascoltando e costruendo politiche condivise.
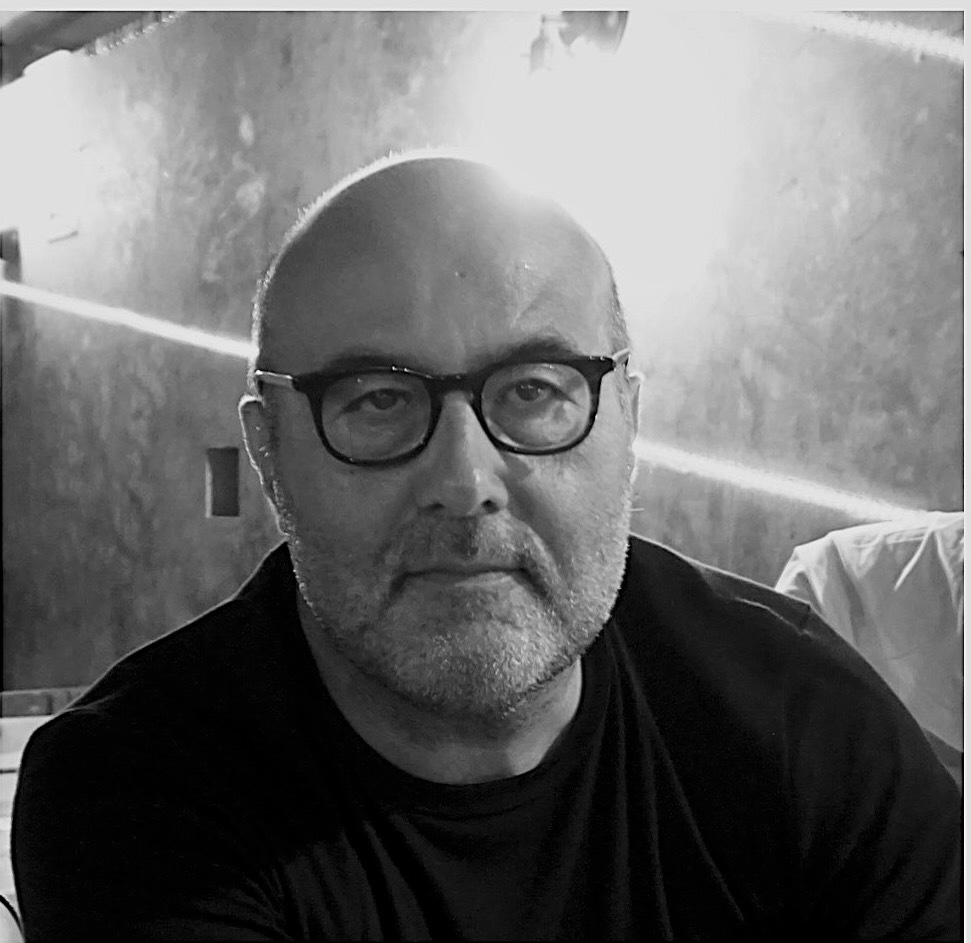
Del resto, viviamo in una società di ‘minoranze’ dove l’appartenenza non è più legata a grandi scelte ideologiche ma spesso è generata da processi di identificazione di gruppo e di ‘identità’ locale.
Anzi, più aumenta la crisi globale più si rafforzano forme di identità locali e a-storiche nelle quali, vista l’incapacità (o impossibilità) di progettare un futuro equo e sostenibile, ci rifugiamo nella riscoperta di un passato che idealizziamo, inventando mondi dove tutto era armonico ma questa ‘invenzione del passato’ è una forma di debolezza nel pensare il futuro.
Rimane il fatto che il nostro Pianeta è in mutazione climatica, molti abitanti del Sud del Mondo ne subiscono gli effetti devastanti senza esserne responsabili, mentre noi, che lo siamo, siamo green finché si resta sul generico e non si mettono in discussione le nostre abitudini dissipative.
Mai come oggi il vecchio slogan ‘pensare globalmente, agire localmente’ è attuale: chi però si prende in carico l’agire globale, visto il discredito delle istituzioni internazionali e visto che molti dei Paesi maggiormente responsabili della crisi climatica pensano più a fare la guerra che a cercare di salvare il Pianeta?”
Alietti
“Spesso le mobilitazioni contro l’ineluttabilità del cosiddetto progresso e/o sviluppo economico, contrassegnato dal prevalere della rendita sul sociale, subiscono la denuncia di seguire la sindrome NIMBY, cioè di agire solo per interessi esclusivi senza pensare alla comunità.
Questa denuncia è da tempo utilizzata dalle élite economiche-finanziarie per indebolire il consenso verso i movimenti che si battono per un modello economico democratico e partecipato.
La questione è aperta, attualmente l’orizzonte è ancora dominato dalla logica estrattivista, quindi la nascita di un movimento allargato, consapevole e capace di limitare e/o cambiare gli effetti più devastanti del fenomeno è auspicabile, per quanto ancora non strutturato. La nascita del Social forum dell’abitare è un passo decisivo in tale direzione”.
Poiché tutto questo ha a che fare con le “piattaforme” on line, siamo di fronte al tramonto della teoria della sharing economy, come ad esempio teorizzata da Jeremy Rifkin, quale antitesi al possesso capitalistico?
Alietti
“La sharing economy è stata un fattore importante per sottrarre al profitto e alla rendita parti significative di vita collettiva.
Il problema è che se osserviamo, ad esempio, talune realtà marginali e periferiche nelle nostre città, lo scambio gratuito tra i residenti è uno strumento di sopravvivenza da sempre attivo, quindi le pratiche di mutuo aiuto raffigurano un circolo virtuoso necessario per la riproduzione sociale.

Le piattaforme digitali sembrano invece essere funzionali a gruppi già beneficiari e in possesso di risorse. In altre parole, l’errore implicito in Rifkin (ma non solo) è relativo alla mancata scomposizione di determinati fenomeni generali nelle loro variabili socio-economiche, che determinano effetti molto diversi.
La vera questione da affrontare nel prossimo futuro è il problema dei beni comuni, la loro preservazione in termini di accessibilità e gratuità, la loro estensione a più ambiti di vita quotidiana e la loro capacità di rafforzare le competenze democratiche in un’epoca dove l’autoritarismo sembra divenire la forma di governo dominante.”
Farinella
“Le piattaforme online senza un’educazione al pensiero critico non sono di nessun aiuto ai processi di cui stiamo parlando, anzi possono diventare spietati strumenti di controllo e orientamento.
Oggi, laddove il problema della ‘tecnica’ non interagisce con quello dell’etica, anche le università tendono spesso più verso la formazione di persone competenti piuttosto che di intellettuali dotati di pensiero critico. La tecnica non è etica in sé, come non lo è la scienza, visto che ad essa possiamo associare l’organizzazione e le pratiche dei campi di sterminio, la bomba atomica, la crisi ambientale: è il suo uso e la sua condivisione che la rende tale. Ritorna la questione posta da Michel de Montaigne e ripresa da Edgar Morin: ‘meglio una testa ben fatta che una testa ben piena’, ma non stiamo andando in questa direzione.”

